“soprintèndere (anche sopraintèndere, sovrintèndere, sovraintèndere) v. intr. [comp. di sopra- (o sovra-) e intendere, sul modello del lat. tardo superintendĕre (calco del gr. ἐπισκοπέω) «sorvegliare»] (coniug. come intendere; aus. avere). – Avere funzioni di direzione, di controllo e vigilanza. Con sign. più specifico, avere la funzione, e quindi la responsabilità, di vigilare sul regolare svolgimento di determinati lavori e attività, di curare la conservazione di beni d’interesse pubblico.”
Checché ne pensi l’ex-premier, sovrintendente non è una brutta parola; ed anche se può suonare un po’ antiquata (quasi ‘napoleonica’), non si può far leva su ciò per sovvertire la logica che questa funzione sottende. Anche perché la presunta ‘modernità’ che le si vuole contrapporre, null’altro è che l’antichissimo sostituire il consumo alla fruizione, e dunque privilegiare l’interesse privato su quello pubblico.
Avere “funzioni di direzione, di controllo e vigilanza”, ed in particolare “curare la conservazione di beni d’interesse pubblico” non è per nulla demodé, al contrario è oggi più che mai estremamente moderno.
La questione – e qui si tratta delle ‘riforme’ messe in atto dal MiBACT negli ultimi anni – va ovviamente osservata in termini sistemici, e quindi a prescindere da qualsivoglia valutazione ad personam, sia essa negativa o positiva.
Se da un lato è ben possibile che, tra le varie Sovrintendenze ai Beni Culturali presenti sul territorio, ve ne siano di mal gestite, o comunque attardate in un tran-tran conservatore (più che conservativo), va tenuto comunque presente che la condizione economica in cui operano è assolutamente insufficiente, e che il prolungato blocco del turn-over nella pubblica amministrazione ne ha impedito il rimpinguamento ed il ringiovanimento. Siamo tra gli ultimi paesi europei, per spesa culturale in rapporto al PIL, nonostante siamo indubbiamente quello che, per vastità del patrimonio, già solo per la mera tutela deve affrontare un onere considerevole. Ed è ovvio che la riduzione di spesa non può che riflettersi su tutto il sistema dei beni culturali, non solo sotto l’aspetto della minor tutela, ma anche sotto quello che impatta sul personale preposto.
 Tenendo presente ciò, l’idea di svincolare dal controllo delle sovrintendenze i ‘grandi musei’ (cioè quelli che rappresentano i maggiori attrattori), affidandoli a direttori-manager dotati di grande autonomia, può ovviamente tradursi in una maggiore ‘dinamicità’ del singolo museo – sulla base della maggiore o minore capacità di chi viene chiamato a dirigerlo – ma al tempo stesso non ci si può nascondere davanti alle conseguenze (pressoché inevitabili) di questo approccio.
Tenendo presente ciò, l’idea di svincolare dal controllo delle sovrintendenze i ‘grandi musei’ (cioè quelli che rappresentano i maggiori attrattori), affidandoli a direttori-manager dotati di grande autonomia, può ovviamente tradursi in una maggiore ‘dinamicità’ del singolo museo – sulla base della maggiore o minore capacità di chi viene chiamato a dirigerlo – ma al tempo stesso non ci si può nascondere davanti alle conseguenze (pressoché inevitabili) di questo approccio.
Poiché l’ovvio intento è quello di incrementare la capacità attrattiva del museo, anche attraverso un implicito meccanismo ‘concorrenziale’, e poiché del resto ciò coincide con l’interesse del direttore-manager, inevitabilmente si rafforzerà la tendenza a perseguire obiettivi quantitativi (maggior numero di visitatori, maggior sbigliettamento, maggiori incassi…), del resto già presente.
Un direttore esterno alla carriera ministeriale, destinato a fine contratto a riallocarsi altrove, non può infatti esimersi dal curare questo aspetto, proprio in funzione del sua futura ricollocazione ‘sul mercato’.
E naturalmente il modo più facile per ottenere questo genere di risultati, è quello di ‘inseguire’ il gusto del mercato, ben più che quello di ‘educarlo’.
Il primo risultato, sarà quindi che – pur restando un’istituzione pubblica, i cui oneri sono a carico dell’erario – tenderà ad assumere sempre più le caratteristiche dell’istituzione privata, almeno sotto il profilo delle politiche culturali. E ciò – va ribadito – a prescindere dagli effetti benefici che ciascuna direzione può apportare al museo, ed effettivamente spesso apporta.
Un altro risultato di questo approccio, è l’impatto sui musei ‘minori’. I quali vedranno crescere le proprie difficoltà ad intercettare l’interesse del pubblico – qui inteso come visitatori – a fronte della crescente competitività del marketing dei grandi attrattori. Con due possibili esiti – o con una combinazione di entrambe: da un lato, la progressiva perdita della già spesso insufficiente capacità attrattiva, e quindi lo ‘svuotamento di senso’ (fermo restando l’onere di spesa), e dall’altro l’inseguimento del mercato nell’unico modo possibile, ovvero la concessione ad uso privato dei propri spazi al fine di reperire risorse.
Quella della ‘messa a reddito’ degli edifici pubblici (soprattutto di quelli più prestigiosi, ovviamente), è del resto ormai un mantra che viene costantemente ripetuto – vuoi come dogma, vuoi come alibi – da ogni amministratore pubblico. E, spesso, questo criterio viene ‘imposto’ dalla Corte dei Conti, che ovviamente (ma fino ad un certo punto…) guarda al tema con occhio ‘ragionieristico’.
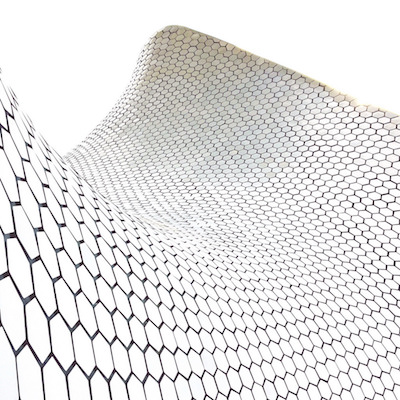 Questo genere di orientamento amministrativo, ormai fattosi vero e proprio atteggiamento ‘culturale’, è paradossalmente alla base di un meccanismo perverso, il cui esito è quello di favorire il depauperamento dei beni pubblici. Molto spesso, infatti, specie nei Comuni con problemi di bilancio (la gran parte, specie quelli più grandi), quest’ottica ‘contabile’, ed al tempo stesso però del tutto astratta, determina enormi impedimenti alla possibilità di affidare spazi pubblici abbandonati (e quindi destinati ad un progressivo, ulteriore deterioramento) per usi civici da parte dei cittadini. L’obiezione ‘contabile’, infatti, dice che quegli spazi potrebbero essere messi a reddito, e che al contrario l’uso civico – essendo gratuito – non determina reddito per l’amministrazione. Con ciò però del tutto ignorando che, da un lato, quegli spazi sono spesso in condizioni di totale abbandono, e la eventuale redditività presupporrebbe degli investimenti di recupero insostenibili, e dall’altro che l’uso civico del bene implica invece un, sia pur parziale, recupero, e soprattutto garantisce la manutenzione, preservandolo quindi da un ulteriore decadimento.
Questo genere di orientamento amministrativo, ormai fattosi vero e proprio atteggiamento ‘culturale’, è paradossalmente alla base di un meccanismo perverso, il cui esito è quello di favorire il depauperamento dei beni pubblici. Molto spesso, infatti, specie nei Comuni con problemi di bilancio (la gran parte, specie quelli più grandi), quest’ottica ‘contabile’, ed al tempo stesso però del tutto astratta, determina enormi impedimenti alla possibilità di affidare spazi pubblici abbandonati (e quindi destinati ad un progressivo, ulteriore deterioramento) per usi civici da parte dei cittadini. L’obiezione ‘contabile’, infatti, dice che quegli spazi potrebbero essere messi a reddito, e che al contrario l’uso civico – essendo gratuito – non determina reddito per l’amministrazione. Con ciò però del tutto ignorando che, da un lato, quegli spazi sono spesso in condizioni di totale abbandono, e la eventuale redditività presupporrebbe degli investimenti di recupero insostenibili, e dall’altro che l’uso civico del bene implica invece un, sia pur parziale, recupero, e soprattutto garantisce la manutenzione, preservandolo quindi da un ulteriore decadimento.
Le politiche di riforma messe in atto dal MiBACT, così come un più generale approccio ai beni culturali fortemente condizionato da un’idea di fondo ‘consumistica’, ‘di mercato’, e quindi in ultima istanza di profitto, stanno in effetti agendo come le due ganasce di una tenaglia, che rischia di sgretolare il patrimonio artistico e culturale italiano, e soprattutto il suo essere considerato un bene comune, con un valore preminentemente culturale e storico, piuttosto che un bene ‘commerciabile’, con un valore eminentemente economico.
A questa tendenza, ormai ben consolidata, fortunatamente cominciano ad opporsi in maniera consistente (ed ancor più, ‘significativa’) alcune importanti amministrazioni comunali, anche politicamente lontane tra di loro.
Ad esempio la città di Napoli è oggi all’avanguardia, per quanto riguarda l’uso civico di spazi pubblici, e gli atti amministrativi che ne sostanziano tale politica sono oggetto di interesse e di studio internazionale. O, più di recente, l’opposizione dell’assessore alla cultura del Comune di Roma all’idea (del MiBACT…) di imporre un ticket d’ingresso al Pantheon, e la volontà di affidare la direzione del museo d’arte contemporanea MACRO al curatore del MaaM, uno spazio ‘occupato’ divenuto oggi un importante centro artistico e culturale.
Oggi, insomma, si pone finalmente la questione se proseguire sulla strada intrapresa ormai da anni, e cioè quella – sostanzialmente – di privilegiare pochi ed abbandonare i più (come del resto è accaduto all’intera società italiana, dove “la ricchezza dell’1% più facoltoso degli italiani (in possesso oggi del 25% di ricchezza nazionale netta) è oltre 30 volte quella del 30% più povero”), o se invece procedere su una strada diversa, per certi versi opposta, che metta al primo posto la ricostruzione di un rapporto tra i cittadini ed il patrimonio culturale, anche attraverso la diffusione di modelli d’affidamento ed uso civico.
Un modello, questo, che produrrebbe anche ricchezza economica (ma non solo), e che soprattutto non la concentrerebbe ulteriormente.
E chi vuol (sovra)intendere, intenda…
autore: Enrico Tomaselli

































