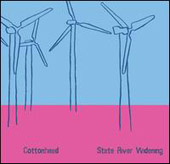 “Cottonhead” è un gran bel disco. Però… però, perché possa essere apprezzato appieno, necessita di una condizione di isolamento ambientale e, possibilmente, esistenziale, di un stato di straniamento dalla realtà, di inquietudine. L’album suona come una colonna sonora, anzi è una colonna sonora, che a tratti rasenta la perfezione. Il film è drammatico, malinconico, visionario, una storia d’amore che vive di sguardi, di ricordi, dove l’atmosfera non è accessorio estetico, ma parte dei sensi, è sogno reso materia musicale.
“Cottonhead” è un gran bel disco. Però… però, perché possa essere apprezzato appieno, necessita di una condizione di isolamento ambientale e, possibilmente, esistenziale, di un stato di straniamento dalla realtà, di inquietudine. L’album suona come una colonna sonora, anzi è una colonna sonora, che a tratti rasenta la perfezione. Il film è drammatico, malinconico, visionario, una storia d’amore che vive di sguardi, di ricordi, dove l’atmosfera non è accessorio estetico, ma parte dei sensi, è sogno reso materia musicale.
“Dreamy”, direbbero gli inglesi, e allora ecco spiegata la condicio sine qua non di cui sopra, perché qual è la condizione migliore per sognare se non la più completa solitudine? Si sentono cascate di chitarre elettriche ed acustiche, archi a profusione, un piano elettrico, una batteria mai invadente. A volte una tromba, come a sottolineare che la dimensione folk, oggi, non può fare a meno di certe interpolazioni. File under “folktronica”, insomma.
‘Crown’ apre l’album splendidamente, un pezzo di black-ambient in slow motion, si insinua leggero fra le pieghe dell’immaginazione palesando la filosofia dell’album: rarefazione e reiterazione. ‘Lowlands’ è ipnosi allo stato puro, la voce di Anne Briggs, regina del folk anni ’60, si interseca alla perfezione con la trama sonora disegnata dai tre musicisti. E siamo solo alla fine del primo tempo. In ‘Desertesque’ rubano (non so quanto consapevolmente) l’attacco di ‘Sowing the Seeds of Love’ e, novelli Orzabal, disegnano un paesaggio sonoro dai contorni indefinibili.
Capita, pure, che ci si smarrisca in deliqui strumentali: ‘Cottonwood’ richiama un po’ troppo da vicino certe atmosfere orientaleggianti, scadendo nel semplicistico; come se a Truffaut si fosse sostituito un videogame. Ma è solo un attimo, un cedimento improvviso, che nulla toglie a quanto di buono i 3 londinesi avevano fino a quel momento dimostrato di saper produrre. Se c’è qualche regista in ascolto, ora sa dove trovarli.
Autore: Andrea Romito































