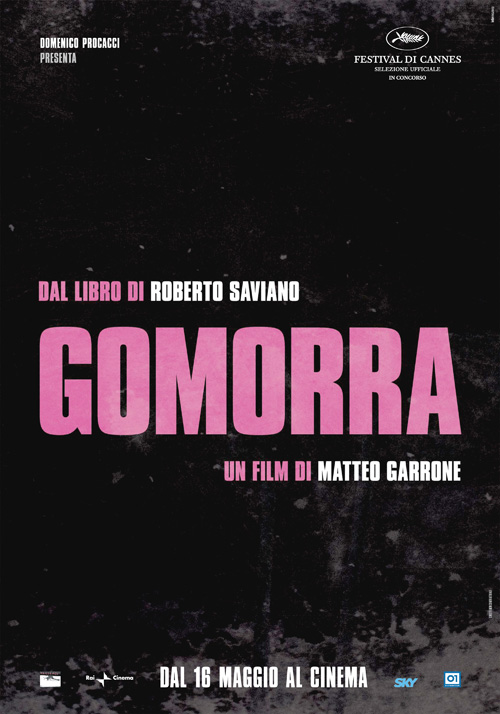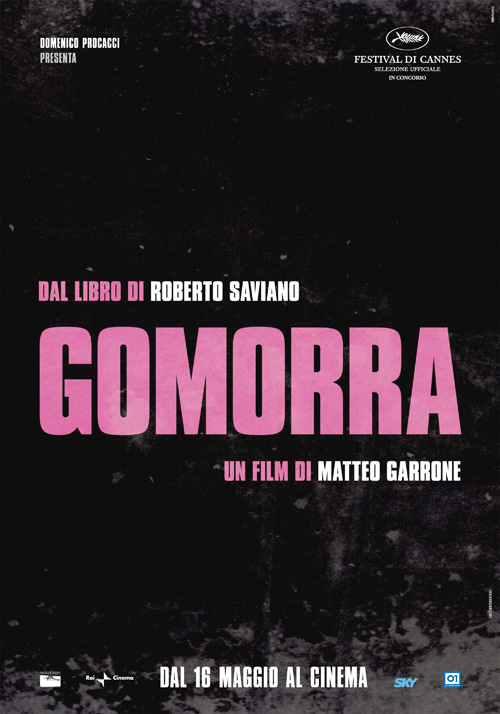 Garrone scatta cinque flash nel quotidiano inferno descritto nel bestseller di Saviano
Garrone scatta cinque flash nel quotidiano inferno descritto nel bestseller di Saviano
Marco dice a Ciro: voglio ciò che mi spetta lo voglio perché è mio, m’aspetta. No, non dice proprio così, ma volendo rendere liriche le gesta dei nostri don Chisciotte in culotte e kalashnikov la citazione ferrettiana ci aiuta a capire. Marco in effetti dice a Ciro, naso di becco, che vuole farsi una lunga pippata di vita, e per farlo deve uccidere i colombiani, fottuti colombiani, perché solo così Tony Montana, suo alter ego fantastico, può finalmente regnare “su Miami, su Casal di Principe, su tutto”.
Poesia bukoskiana dalla Malabolgia e bagno di umori nella terra maledetta dai nomi poco esotici Scampia, Casale: è l’insegnamento di Gomorra, city of god/land of god, film caravaggesco, impalcato su lame di luce (le azioni umane) a far risaltare il nero che precipita sulle miserie della generazione x, che non parla, ulula, in linguaggio extraterrestre.
Più che svolgere una trama vera e propria – il film è suddiviso in cinque vicende – il regista sfoglia diapositive da comuni (?) contesti di degrado e i caratteri prescelti sono fini a se stessi, la loro maschera tragica non serve per raccontare una storia, “è” la storia. E’ vero, prima delle sentinelle minorenni delle Vele, “Ragazzi fuori” di Marco Risi ci ha già rubato l’infanzia 18 anni fa. Diciotto anni fa, chi scrive, capì attraverso il verismo della gomorra sicula di Risi junior che un altro mondo è impossibile, che la carne della peggio gioventù si può corrompere fino alla nausea (e ora Wenders con il nuovo film “Palermo Shooting” vorrebbe fare un richiamo di vaccino al quartiere Zen: non ci riuscirà, non in egual misura).
Dopo Risi, e altri, sale sul ring Garrone, che però gode di qualche arma in più. Primo, prende le mosse dall’inarrivabile no fiction del libro di Roberto Saviano, in verità difficilmente rappresentabile se non a flash: il regista romano può (sof)fermarsi al massimo per un succulento pit stop a Gomorra (niente “kolossal” perché Procacci, il produttore, non ha i soldi della Warner Bros). Seconda arma: la fantasia malata dei napoletani. Fantasia nel creare un discount di droga con un organigramma da multinazionale; la fantasia di pensare “c’è tutta questa terra qua, perché non ci smaltiamo scorie tossiche?”, tanto i tumori non stroncano veloci come la malaria; la fantasia di cucire abiti impilati a stock senza sapere che vestiranno Scarlett Johansson.
Sulla apocalittica ordinarietà del male meridionale, modello di follia più europeo nei toni rispetto a certi disturbanti racconti asiatici (Kim ki duk), Garrone aziona ciò che gli piace di più: il naturalismo epico, la quotidianità decomposta sbirciata con gli occhi del letterato mai snob, il dramma “teatrale” reso da una fotografia satura fino all’eccesso, e da una camera a mano che manda in onda riprese “uniche” come su Ciro, ‘o pisiell’, uno scheletrino d’ossa che guida il Transalp, moto di grossa cilindrata, e quasi sbanda e quasi cade. “Uniche” alla maniera di Paul Greengrass in “Bloody Sunday”, o dell’Innaritu di “Amore Perros”. Ma i paragoni potrebbero continuare.
Non fa sforzi particolari Toni Servillo, ormai attore italiano di punta: recita la parte dello stakeholder di rifiuti tossici, la figura più atroce, ma con misurata compostezza, come vuole il personaggio. Ottimo il lavoro filologico sulla lingua del film: un napoletano da playstation, onomatopeico, cacofonico, i sottotitoli stavolta sono davvero inevitabili. Rispettata anche la sfumatura marcata tra vernacolo partenopeo e casertano (anche se Marco e Ciro non parlano con l’accento della Terra di Lavoro, ma sto a guardà il capello): il “lessico vivente” per il romano Garrone si compone di quattro firme, gli sceneggiatori Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio, Massimo Gaudioso. Più gli indispensabili spacciatori di Scampia.
Autore: Alessandro Chetta