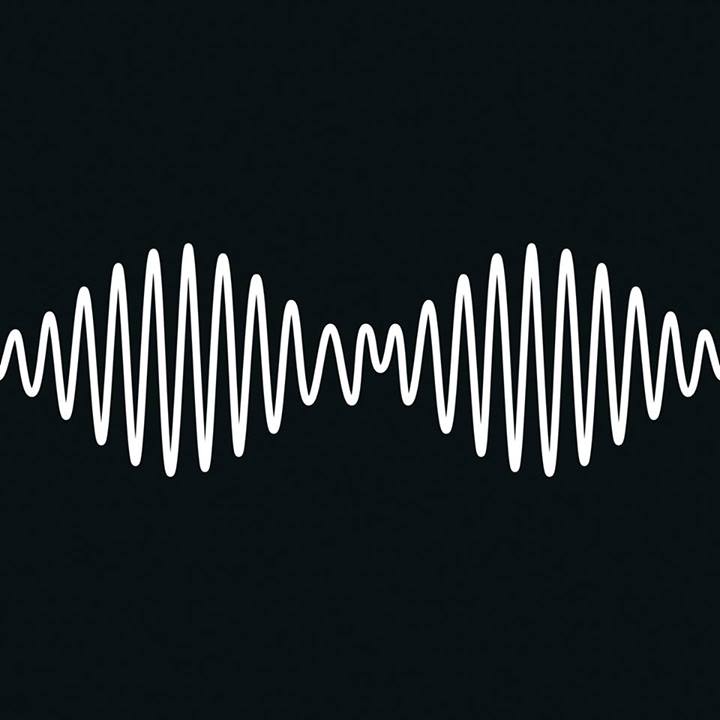 Si presentano così: “Hello, we’re Arctic Monkeys from Sheffield, USA”. I quattro sbarbatelli inglesi in parka di “Whatever people say I am, that’s what I’m not”, primo album uscito appena nel 2006, sono ormai lontani anni luce.
Si presentano così: “Hello, we’re Arctic Monkeys from Sheffield, USA”. I quattro sbarbatelli inglesi in parka di “Whatever people say I am, that’s what I’m not”, primo album uscito appena nel 2006, sono ormai lontani anni luce.
Nessuna paura di “sporcare” il loro sound e piena fiducia all’influenza di Josh Homme dei QOTSA: questo “AM”, dopo la (piacevole) rottura con il passato di “Humbug” e la transizione stoner di “Suck it and See”, è la prova che l’ “americanizzazione” è completa.
Un disco che appare minimale nelle scelte estetiche (copertina e titolo, chiari omaggi a “VU” dei Velvet Underground), ma che presenta una miriade di piccoli particolari ben curati che, paradossalmente, formano nel complesso un disco essenziale, disegnato per essere il classico album pop-rock pepato da varie influenze inaspettate, segno della maturità e della sfrontataggine delle scimmie artiche.
Nelle dodici tracce di “AM” ci sono i ritmi sintetici della West Coast, il beat dell’hip hop, i cori pop di Marvin Gaye e delle boy band anni 90’, le “dry guitars” dei QOTSA e dei Black Keys (al fianco degli Arctic per tutto il loro tour americano), il glam dei T-Rex, la residua influenza brit dei Beatles (scusate, li vedo dappertutto) e potrei continuare quasi all’infinito. Quello che mi sorprende maggiormente, però, è il cambio “concettuale”: a parte i testi, sempre di buon livello ma mai alla pari con “Humbug”, Alex Turner abbraccia totalmente la figura del “frontman”.
Un nuovo personaggio che lascia interdetti, indecisi tra una forzatura commerciale e un’evoluzione fisiologica nella carriera dell’artista. I preamboli alle canzoni durante i live o le interviste da icona del rock non fanno di Turner un “crac” della comunicazione, ma probabilmente l’evoluzione musicale del gruppo ha portato con sé una pari e naturale evoluzione del cantante: i tempi del brit rock e del timido inglesino che strimpella alla chitarra dovevano finire per forza di cose. Trasformazione che non si ferma all’immagine: il dialetto inglese di Sheffield, quello incomprensibile, veloce e dalle vocali aperte fa spazio ad un accento americano del Bronx, che sfiora il flow tipico del r’n’b in alcuni pezzi del disco. I fans rabbrividiscono urlando la fine dei “vecchi” Arctic Monkeys, ma è risaputo che chi guarda le cose troppo da vicino rischia di perdere l’oggettività: il passo, avanti o indietro che sia, è stato fatto nei modi e nei tempi giusti.
Il disco parte con “Do I Wanna Know”, pezzo che rappresenta perfettamente la sensualità di “AM”. Il ritmo suadente del beat in sottofondo, la venatura hip-hop e le sovrapposizioni di voci che troveremo in tutto l’album, spianano il campo al secco riff di chitarra a ripetizione (Cause there’s this tune I found/that makes me think of you somehow/when I play it on repeat): ingredienti che ne fanno una canzone attraente, con quel tocco di progressive che le permette di non decadere nel commerciale. La vorace “R u Mine?”, a parte il titolo da “bimbiminchia”, è il legame con il passato, con gli Arctic primordiali, non a caso è stata scritta molto prima degli altri pezzi. Il riff sabbathiano anni ’70 e la velocità delle strofe ci riporta a cavallo tra “Favourite Worste Nightmare” e “Humbug”, con l’impressione che le idee c’erano già a quei tempi e che lo sviluppo definitivo sia stato affidato a Josh Homme (santo subito) e, quindi, al nuovo album.
“One for the road” sembra scritta per i componenti di una di quelle boyband anni 90’ che, condizionati dall’avanzare dell’hip hop, giocavano a fare i rapper. I cori in questo pezzo superano un po’ il limite: l’intenzione è glam, ma l’unica cosa che trasmette quel sound è l’assolo di chitarra finale. Resta divertente ascoltare Turner “rappare” nelle strofe, con la cadenza di cui parlavamo prima, e magari immaginarlo in giro nel ghetto lasciandosi indietro il capello pomatato e la giacca di pelle. “Arabella” è una delle canzoni migliori dell’album: l’apertura è ancora una volta hip hop, un po’ da colonna sonora di GTA. Partito il ritornello la canzone viene spezzata in due: i riff quasi da garage rock ricordano i primi Strokes, senza dimenticare le venature Beatles (omaggiati anche nel testo) che fanno di questa infuocata ballata un pezzo destinato a funzionare. Con “I Want it all” i quattro ragazzi di Sheffield mettono sul tavolo tutte le loro intenzioni glam: il riff ed il basso a “salire” sono figli degli anni 80’ e dei T-Rex, i falsetti ispirati dal grande Marvin Gaye.Tutto resta però al di sotto delle aspettative, gli AM non dialogano bene con questo genere di sound. A dividere in due “AM” arriva la classica ballata, “No.1 Party Anthem”, discendente da “Suck it and See” e dal lavoro solista di Turner per Submarine. Un’esperienza quasi chill, l’ennesimo omaggio a John Lennon e la prima di una serie di ballate malinconiche presenti nella seconda parte dell’album.
La seconda viene subito dopo, ed è “Mad Sounds”, pezzo datato anni 80’ e scritto dal primo produttore degli Arctic Monkeys Alan Smith. Il tamburello e la melodia malinconica ci rimandano direttamente a “Transformer” dei Velvet Underground, un modo nostalgico di omaggiare la grandezza di Lou Reed, senza cimentarsi in copie mal riuscite. “Fireside” è un’avventura ritmica quasi estranea al resto dell’album, un pezzo tutto drumming, chitarre distorte e “on the road” americano che ricorda molto la collaborazione tra Turner e Miles Kane sfociata nei “The Last Shadow Puppets”. La sarcastica e suadente “Why’d You Only Call Me When You’re High?” è il pezzo più commerciale di “AM”, ma anche uno dei meglio riusciti: il beat hip hop è degno di Dr Dre, la canzone ti conquista subito, nei suoi due minuti e mezzo abbondanti. Una delle storie “notturne” tra Alex (o sarebbe meglio chiamarlo erroneamente Andy come l’autore dell’intervista per RS Italia?) ed una delle sue muse, magari non più inglese ma americana.
“Snap out of it” non mi piace: l’inizio conserva l’animo brit degli Arctic, soprattutto nella cadenza. Una volta iniziati strofa e ritornello sembra di essere ad High School Musical con l’esagerazione dei falsetti ed un sound troppo pop, sempre interpretato alla loro maniera. “Knee Socks” è il pezzo di Josh Homme e della sua collaborazione, 30 secondi deliranti di un coro in cui canta in background, il tutto nel bel mezzo di una canzone che fa parte del lato accattivante molto pronunciato dell’album: la strofa sa di funky e ricompaiono le suadenti chitarre glam.
“AM” si chiude con “I Wanna be Yours”, languido e nostalgico contenitore delle paura del frontman (I will never rust), quello che c’è di vero dietro al nuovo personaggio sfrontato e gelatinato rappresentato da Turner.
Non è difficile trovare le influenze di altre band ed altri generi in questo nuovo album degli Arctic Monkeys, ma credo che il loro sia un lavoro da concepire molto più a fondo. E’ da apprezzare il coraggio di quattro talentuosi ragazzi che, appena 7-8 anni fa, furono capaci di battere il record di vendite con il loro disco d’esordio. Snaturare attraverso vari passaggi il proprio sound è una scelta difficile, è un modo per ricercare la svolta ed entrare nell’olimpo delle grandi band, quelle del “qualsiasi cosa facciano li adoro”.
Alex Turner (voce, chitarra ritmica e solista), insieme a Jamie Cook (chitarra ritmica e solista), Nick O’Malley (basso, seconda voce) e Matt Helders (batteria, seconda voce), affronta impettito questa nuova avventura, con un ghigno deciso e la voglia di essere il rappresentante di una generazione orfana di band trascinanti.
La grande eterogeneità di questo “AM” denota ancora qualche insicurezza, ma la loro prolifica qualità (5 album in 8 anni) ci lascia ben sperare che questa, o al massimo la prossima, sia la volta buona.
http://www.arcticmonkeys.com
https://www.facebook.com/ArcticMonkey
autore: Natale De Gregorio

































